di Dante Iagrossi. Ogni popolo, fin dagli albori delle civiltà, ha creato miti e leggende fantasiose e suggestive sul Sole, che ne testimoniano grande riconoscenza ed ammirazione. In particolare, per gli aborigeni australiani, il Sole era come una donna che ogni giorno si svegliava nel suo accampamento situato ad Est, accendeva un fuoco e preparava una torcia di corteccia, portata attraverso il cielo. Prima di partire, si decorava con polvere sottile di ocra rossa e gialla, dispersa sulle nuvole, per cui l’alba appariva rossastra. Quando raggiungeva l’Ovest, stanca, sudata e sporca, si lavava e rinnovava il trucco col giallo ed il rosso, che coloravano il tramonto. Infine, con un viaggio sotterraneo, che forniva calore della torcia alle piante per la crescita, ritornava al suo accampamento in Oriente.
Carta d’identità. Il Sole, la stella più vicina a noi, a circa 150 milioni di km, è una nana gialla, dal diametro equatoriale di 1,4 milioni di km, con una massa 330.000 volte quella terrestre. Contiene 750 volte la massa di tutti i pianeti del Sistema solare. È composto soprattutto da Idrogeno (96%) e in parte di Elio (4%). La temperatura di superficie è di 5.500 gradi C, quella del nucleo centrale arriva ai 15 milioni. Il periodo di rotazione, con velocità di 1993 m/s, è di 25 giorni all’equatore, di 34 ai poli, mentre quello di rivoluzione in orbita ellittica attorno al centro della nostra galassia, con velocità di 251 km/s, è di circa 250 milioni di anni. Si pensa che finora il Sole abbia completato la sua orbita solo una ventina di volte.
Struttura. Nucleo, zona radiativa, convettiva; in superficie, fotosfera, poi cromosfera e corona.

Produzione di luce e calore. Nel nucleo, con pressioni e temperature molto elevate, avvengono le reazioni di fusione nucleare, che trasformano i nuclei dell’idrogeno in nuclei di elio, ad un tasso di 600 milioni di tonnellate al secondo. La perdita di massa è trasformata in luce e calore, indispensabili alla vita sulla Terra. Senza Sole non sarebbe possibile ai vegetali svolgere la fotosintesi clorofilliana, per cui gli erbivori, i carnivori non avrebbero nutrimento, cioè in breve si estinguerebbero praticamente tutte le forme di vita.
Attività. La superficie solare si presenta granulare, molte zone scure, le macchie solari, dotate di temperatura inferiore di circa 1500 gradi in meno rispetto alle chiare. Esse in coppia con poli magnetici opposti hanno al centro una parte scura (ombra) e attorno una più chiara (penombra). Esse seguono la rotazione terrestre ed impiegano quindi 27 giorni per ritornare in posizione iniziale. Presentano un massimo ogni 11 anni, il prossimo ci sarà nel 2024.
Presso le macchie ci sono protuberanze, più luminose, nubi archiformi di Idrogeno, che arrivano a 40mila km di altezza, e i brillamenti, brevi getti esplosivi di gas e radiazioni. Si producono anche flussi di particelle che arrivano sulla Terra, determinando le bellissime aurore colorate.
Eclissi. A volte la Luna si trova in congiunzione, dalla stessa parte del sole rispetto alla Terra, in posizione tale che il suo cono d’ombra oscura del tutto il disco solare (eclissi di Sole), oppure in parte (eclissi anulare).
Ultime scoperte. Il 15 giugno 2020 la sonda Solar si è trovata nel punto più vicino al Sole, a circa 77 milioni di km, e mediante un coronografo, ha scoperto micro-brillamenti nella corona, mai visti prima, sparsi dovunque, che pur deboli da soli, insieme potrebbero diventare pericolosi. Essi potrebbero provocare un rilevante aumento di temperatura della corona, già molto più elevata di quella della superficie solare.
Alla fine di novembre 2020, con l’inizio di un nuovo ciclo di attività, si è verificata la più grande eruzione degli ultimi tre anni, di classe M4,4, di medie dimensioni, in scala da 1 a 9. Si è diffuso materiale solare come una gigantesca nuvola di gas e campi magnetici (CME, espulsione di massa coronale). Inoltre si è notato anche uno sciame di particelle energetiche solari veloci, guidate dai campi magnetici che fluiscono dal Sole, a causa della rotazione solare, spinte indietro a spirale. Il fenomeno è stato generato da una macchia presente nella parte orientale dell’emisfero sud del Sole.
La fine. Il Sole per adesso si trova in una situazione stabile di equilibrio tra la forza compressiva gravitazionale e l’espansiva di quella nucleare. Quando però l’idrogeno si esaurirà, il nucleo avrà una contrazione, con aumento di temperatura, che a sua volta produrrà una espansione termica degli strati sovrastanti: gigante rossa, che inghiottirà Mercurio, forse anche Venere. Poi, sia pure per poco, si riaccenderà la fornace con trasformazione di elio in carbonio. Infine, dopo l’ultima contrazione, sarà una nana bianca con nebulosa planetaria, di luminosità tipo l’attuale, per poi spegnersi del tutto, divenendo una nana nera. Triste destino per una stella che ha permesso lo sviluppo della vita sul nostro pianeta, per un lunghissimo arco temporale.
Impianti solari. Abbiamo ancora da imparare tante cose sul Sole, ma per il momento ne sfruttiamo l’energia enorme e pulita, con impianti fotovoltaici e solari sempre più diffusi. I primi trasformano le radiazioni solari in energia elettrica mediante pannelli di silicio. Gli impianti solari invece sono collegati a serbatoi di accumulo che riscaldano l’acqua, al posto di comuni caldaie e scaldabagni. Quelli solari a concentrazione usano specchi per convogliare il calore in caldaie capaci di avviare impianti termoelettrici. Infine il solare passivo sfrutta in modo naturale i raggi solari con la costruzione di edifici, capaci di far passare una maggiore quantità di radiazioni.
Allora gli esseri umani potranno sopravvivere, ma soltanto altrove, molto lontano, su qualche altro pianeta, se vi avranno creato per tempo le condizioni necessarie tramite le loro acquisizioni scientifiche e tecnologiche avanzate. (crediti fotografici: informazioneambiente.it – repubblica.it). Dante Iagrossi, Caiazzo. VIDEO (SDO, dieci anni col Sole in fronte):


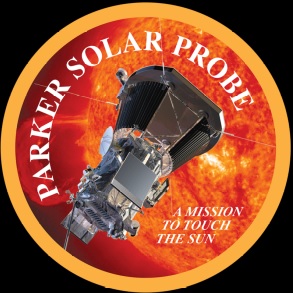 Parker Solar Probe
Parker Solar Probe Solar Orbiter
Solar Orbiter

 Insignificante. Così definiremmo questa stella se si trovasse in qualunque altro posto tra i 200 miliardi (circa) di stelle che formano la Via Lattea. Invece la sua posizione, a soli 4,24 anni luce di distanza da noi, la rendono speciale: è la stella più vicina al Sole, al nostro Sistema Solare. Almeno per adesso, per effetto della sua orbita intorno alle sorelle di maggiori dimensioni.
Insignificante. Così definiremmo questa stella se si trovasse in qualunque altro posto tra i 200 miliardi (circa) di stelle che formano la Via Lattea. Invece la sua posizione, a soli 4,24 anni luce di distanza da noi, la rendono speciale: è la stella più vicina al Sole, al nostro Sistema Solare. Almeno per adesso, per effetto della sua orbita intorno alle sorelle di maggiori dimensioni. 
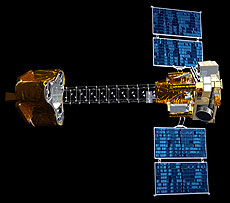




 A Torino il 4 gennaio scorso non è stato possibile osservare l’eclissi di Sole. Il cielo è stato coperto da nuvole per l’intera giornata. Possiamo però osservare i video ripresi in altre parti d’Italia o d’Europa e messi in rete. Ad esempio quello ripreso
A Torino il 4 gennaio scorso non è stato possibile osservare l’eclissi di Sole. Il cielo è stato coperto da nuvole per l’intera giornata. Possiamo però osservare i video ripresi in altre parti d’Italia o d’Europa e messi in rete. Ad esempio quello ripreso 