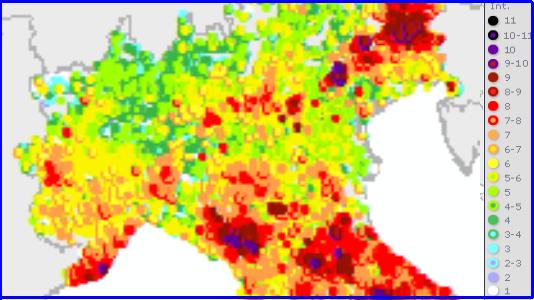Nel 1985 fu approvata una legge della Regione Piemonte che, con lo scopo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio paleontologico dell’astigiano, istituiva la Riserva Naturale di Valle Andona, Valle Botto e Val Grande, ampliata ampliata nel 2003. La Riserva rientra nel Parco Paleontologico Astigiano, insieme ad altre tre Aree protette: il Parco Naturale di Rocchetta Tanaro, la Riserva Naturale della Val Sarmassa e le nuove Riserva Naturali della Piana del Tanaro.
Sui fossili dell’astigiano, qualche mese fa è stato presentato l’ultimo libro della scrittrice e giornalista astigiana Laura Nosenzo: “Fossili e Territori – Scoperte straordinarie sulle colline astigiane“. Il libro, interessante e utile anche sul piano didattico, tratta la storia dei fossili principali custoditi nel Museo Paleontologico di Asti e descrive le località in cui sono stati ritrovati. Quelle astigiane sono eccellenze paleontologiche che meriterebbero più attenzione e maggiori visite anche da parte delle numerose scolaresche dell’area torinese.
In mostra al Museo si trovano fossili di conchiglie, di balenottere e di delfini, risalenti ad alcuni milioni di anni fa, quando al posto della Pianura Padana c’era il mare. Ma c’è anche molto altro, tutto sapientemente catalogato, facilmente fruibile da famiglie, studenti ed esperti del settore: la più antica balena del Mediterraneo (Tersilla) ritrovata in provincia di Alessandria, località Moleto; la balenottera di Montafia, in ottimo stato di conservazione; un antenato degli attuali delfini e orche, il delfino di Camerano Casasco (AT) e tanto altro. Per saperne di più sul Museo: Museo Paleontologico dell’astigiano.

Un gruppo di specialisti paleontologi ha pubblicato un volume scientifico molto esaustivo sui fossili dell’astigiano: “Valle Andona, Mare e Fossili”, in italiano e in inglese.
Dal sito del Museo: “L’attuale allestimento temporaneo del Museo descrive i più importanti eventi geo-paleontologici degli ultimi 25 milioni di anni, compresi tra il Miocene ed il Pliocene, con una carrellata sui principali organismi, soprattutto molluschi, che caratterizzavano gli ambienti passati.
I reperti più significativi – alcuni unici al mondo – sono i resti scheletrici fossili di cetacei astigiani, sia misticeti (balene) che odontoceti (delfini), risalenti all’epoca pliocenica (tra 5,3 e 1,8 milioni di anni fa) quando tutta la Pianura Padana era occupata dal mare. Al termine del percorso espositivo un piccolo ma affascinante acquario riproduce, con po’ di fantasia, l’ecosistema sub-tropicale del mare padano di 25 milioni di anni fa.
Il Museo è ospitato nel “Palazzo del Michelerio”, in origine un monastero risalente alla metà del secolo XVI e attualmente di proprietà dell’Agenzia Territoriale per la Casa Piemonte Sud. Per completare il percorso museale è sufficiente un’ora circa. Consigliata la visita guidata”.