 È iniziato novembre, il mese delle leonidi, meteore che, quando arrivano nella nostra atmosfera, lasciano una scia luminosa a causa dell’attrito e sembrano provenire tutte da una zona della volta celeste in cui si trova la costellazione del Leone.
È iniziato novembre, il mese delle leonidi, meteore che, quando arrivano nella nostra atmosfera, lasciano una scia luminosa a causa dell’attrito e sembrano provenire tutte da una zona della volta celeste in cui si trova la costellazione del Leone.
Nell’antichità il cielo, le sue luci e le forme dei vari corpi celesti furono osservati ad occhio nudo e affascinarono milioni di persone. Nel corso dei secoli però a queste osservazioni, basate solo sull’uso della vista, si sono aggiunti vari strumenti: lo gnomone e le meridiane per misurare il tempo; il compasso, per misurare distanze tra due punti; il bastone di Giacobbe, antenato del sestante, utilizzato per determinare l’altezza di un astro rispetto all’orizzonte o la distanza angolare fra due astri; l’astrolabio, una sorta di planisfero girevole utilizzato anch’esso per determinare l’altezza degli astri sull’orizzonte, oggi quello “a prisma” permette di determinare con precisione latitudine e longitudine; la bussola, per l’orientamento. Il primo cannocchiale ottico che ha permesso di fare molta chiarezza rispetto alla confusione che regnava riguardo alle caratteristiche e ai movimenti di Luna, Terra, Sole, pianeti e stelle, venne costruito da Galilei nel 1609. Il primo telescopio riflettore invece fu progettato da Newton nel 1668 e raccoglieva la luce per mezzo di uno specchio concavo che la inviava ad una certa distanza a un secondo specchio e poi arrivava all’oculare. Quattro anni dopo arrivò il telescopio del francese Guillome Cassegrain che venne perfezionato da Friedrich Wilhelm Herschel con uno specchio convesso che rifletteva su un oculare i raggi luminosi provenienti da uno specchio concavo primario. Oggi i telescopi usati dagli astrofili amatoriali sono, generalmente, rifrattori. Non trascuriamo i binocoli. Un buon binocolo, avendo un campo visivo molto ampio, è adatto per osservare corpi celesti di grandi dimensioni: la Luna, le comete, ammassi stellari (ad esempio le Pleiadi). Sulla Terra però dai vari corpi dell’universo non arriva solo luce ma anche onde radio. I primi strumenti adatti a captare questo tipo di onde furono costruiti negli anni successivi alla seconda guerra mondiale. Oggi alcuni di questi radiotelescopi hanno dimensioni notevoli. Tra i più importanti bisogna segnalare quello di Effelsberg in Germania con una parabola di 100 m di diametro; quello di Arecibo a Porto Rico, di 305 m di diametro; il MERLIN di Manchester in Inghilterra; il VLA (Very Large Array) in Nuovo Messico (USA), con 27 antenne di 25 m di diametro ciascuna, disposte lungo un tracciato a “Y” di 36 km. Anche i telescopi ottici hanno raggiunto dimensioni considerevoli: il più grande è il Keck di Mauna Kea alle Hawaii, posto ad un’altitudine di oltre 4000 metri e costituito da due telescopi con lenti di 10 m di diametro.
Un posto di primo piano spetta al telescopio spaziale Hubble che, superando le distorsioni e il filtro dell’atmosfera, ha trasmesso sulla Terra immagini eccezionali. È stato lanciato nel 1990 e posto a un’altezza di circa 550 km, la sua orbita intorno alla Terra dura circa un’ora e mezza. Ha subìto diversi interventi di manutenzione, l’ultima nel 2009. Hubble ormai è alla fine della propria carriera e nei prossimi anni ci aspettiamo grandi cose da un altro osservatorio spaziale, in orbita intorno alla Terra: Kepler, gestito dalla NASA. Nei primi mesi di osservazione, Kepler ha individuato oltre mille probabili pianeti extrasolari. Se alcuni di questi hanno caratteristiche simili alla Terra è tutto da verificare.
Tra i radiotelescopi terrestri, gli studiosi si aspettano molti risultati da una batteria di antenne in costruzione sul Cerro Paranal, monte della Cordigliera della Costa ai confini del deserto di Atacama, in Cile. La località si trova in corrispondenza del Tropico del Capricorno, a 23° 30’ latitudine Sud, verso il confine con Bolivia e Argentina ed è tra quelle più aride e meno inquinate del pianeta. L’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (Alma), sarà completato nel 2013 e sarà composto da ben 66 antenne, di cui 25 di produzione statunitense, altre 25 costruite in Europa e 16 realizzate in Giappone. 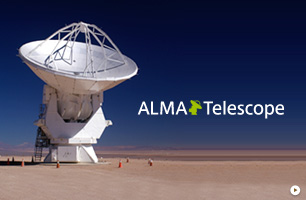 Funzioneranno come un’unica enorme parabola. Un grande sforzo scientifico, tecnologico e economico che in Europa vede impegnate la tedesca MT-Mechatronics, due grandi aziende anche italiane: la European Industrial Engineering (Eie Group) e la Thales Alenia Space, ben conosciuta a Torino (a causa della crisi economica, l’azienda ha annunciato circa 300 esuberi di tecnici altamente specializzati) per la sua sede in corso Marche. A detta di molti, le antenne italiane realizzate in fibra di carbonio hanno eccellenti prestazioni e resistono bene all’escursione termica dell’Atacama la cui temperatura varia da –20 °C a +40 °C. Tra i numerosi progetti dell’ALMA c’è anche lo studio del buco nero supermassivo che si trova nella zona centrale della Via Lattea, a circa 26mila anni luce dalla Terra.
Funzioneranno come un’unica enorme parabola. Un grande sforzo scientifico, tecnologico e economico che in Europa vede impegnate la tedesca MT-Mechatronics, due grandi aziende anche italiane: la European Industrial Engineering (Eie Group) e la Thales Alenia Space, ben conosciuta a Torino (a causa della crisi economica, l’azienda ha annunciato circa 300 esuberi di tecnici altamente specializzati) per la sua sede in corso Marche. A detta di molti, le antenne italiane realizzate in fibra di carbonio hanno eccellenti prestazioni e resistono bene all’escursione termica dell’Atacama la cui temperatura varia da –20 °C a +40 °C. Tra i numerosi progetti dell’ALMA c’è anche lo studio del buco nero supermassivo che si trova nella zona centrale della Via Lattea, a circa 26mila anni luce dalla Terra.
Le immagini sono tratte da: http://alma.mtk.nao.ac.jp/e/aboutalma/outline/00.html e
http://www.sciencedaily.com/releases/2008/02/080215151212.htm
Per una serie di video con immagini inviate dal telescopio Hubble:
Per approfondimenti sul radiotelescopio ALMA: http://www.almaobservatory.org/ (in inglese e spagnolo).
