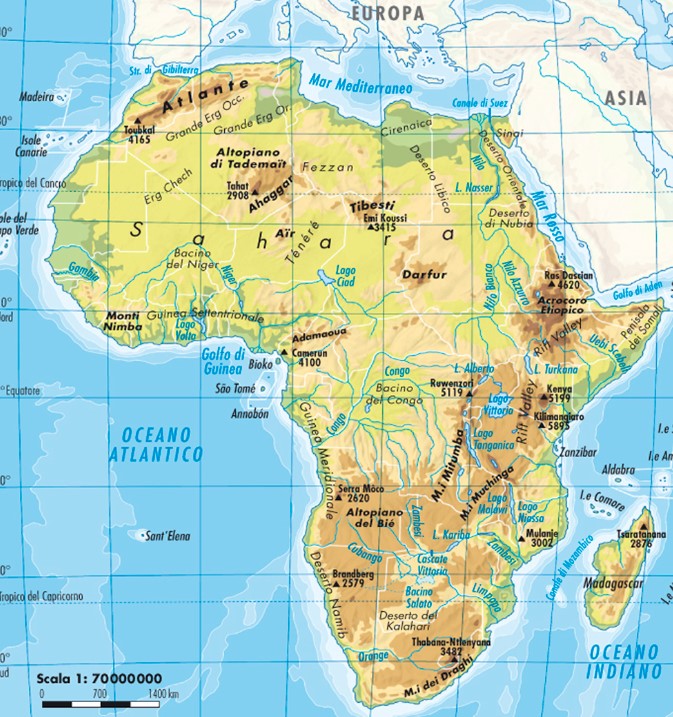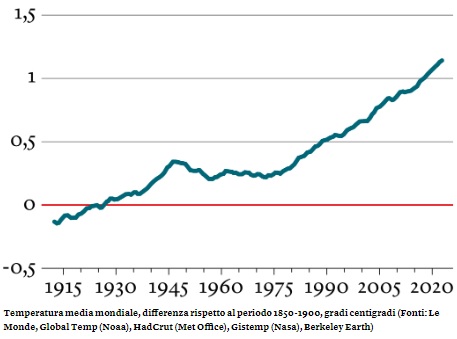Dante Iagrossi. Secondo una leggenda sarda, un pastore quasi sempre isolato dalla comunità vicina, conduceva il suo gregge al pascolo di prima mattina. Un giorno, salendo in montagna, visto un muflone, gli puntò il fucile contro, ma quello gli confessò di essere lo spirito di suo nonno. Allora il pastore, impaurito, corse subito alla sua baracca, dove si era acceso un incendio, che fece in tempo a bloccare. Quindi il muflone gli permise di salvare la sua abitazione.

Caratteristiche generali
Il muflone europeo (Ovis gmelini musimon), mammifero artiodattilo, ungulato, della famiglia dei Cervidi, discende da quello asiatico. Vive in particolare in Sardegna, Corsica, Cipro, e in altre isole minori, ma dal 1700 è stato introdotto anche in Europa, poi in Cile ed Usa. Il pelo si inscurisce d’inverno, ma è bianco sul muso, parte interna delle orecchie, attorno agli occhi, sotto e dietro. I maschi si distinguono dalle femmine, di colore marroncino, per due grosse corna ricurve, fisse su base ossea, ambiti trofei di caccia. Tre le varietà: oltre alla sarda, anche quella della Corsica e di Cipro.
Habitat
Si trova specialmente in zone collinari e rocciose, in cui si rifugia quando è in pericolo. Comunque si po’ spingere anche in foreste di conifere e latifoglie, fino ad altezze di circa 1500 metri.
Struttura sociale
Mentre le femmine con i loro piccoli vivono in grossi gruppi, i maschi, in genere coetanei, vivono in altri, separati da loro e più ristretti. Invece quelli più vecchi preferiscono stare soli. Non sono territoriali, non avendo ghiandole odorifere adeguate per contrassegnare confini. A volte ci possono però essere lotte per una certa zona o per l’accoppiamento.
Alimentazione
Animali da pascolo, oltre che di erbe, si nutrono anche di tanti altri vegetali e varie ghiande, anzi possono brucare persino piante abbastanza dure, evitate da altri animali.
Comportamento
Piuttosto diffidente verso chi potrebbe disturbarlo, appare più pacifico nelle zone più tranquille. Più corridore che arrampicatore, si accorge di potenziali pericoli grazie all’udito, l’olfatto e la vista molto fini.
Corteggiamento e riproduzione
Nel mese d’ottobre, o anche dopo, in zone più fredde, i maschi si avvicinano ai branchi femminili, attratti dal loro profumo. Entrano in competizione per attirarle. Con cozzate frontali di corna, o con vigorose spallate. Nel primo caso essi, dopo una breve rincorsa, si saltano addosso con forte impatto, persino sonoro, udibile anche da lontano. Nel secondo, invece, meno violento, essi si spingono l’un l’altro, con corna incrociate. Da notare però che si tratta di comportamenti ritualizzati, senza grosse ferite, per stabilire solo chi è il più forte, senza la soppressione del perdente. Tra marzo ed aprile, le femmine lasciano il gruppo e, dopo circa 5 mesi di gestazione, partoriscono isolate uno o due piccoli, già capaci di muoversi, allattati inizialmente ogni 15 minuti, per sei mesi. La maturità sessuale si ha a circa un anno e mezzo di età. Poi d’estate femmine e piccoli si riuniscono in una quarantina. I maschi vivono per 12 anni circa, le femmine circa 15.
Situazione e problematiche attuali
I mufloni, in base alla convenzione europea di Berna (1982), sono specie protetta, ma in Italia ciò si attua realmente solo nell’Asinara, con territorio inaccessibile ai cacciatori, e nella riserva privata di Capo Figari, isola Figarolo, con adeguati controlli. A volte però ci sono iniziative non positive se considerate a lungo termine. Nell’isola del Giglio, ad es., negli anni ’50 furono introdotti 7 mufloni, che però nel tempo sono cresciuti molto in numero, arrivando a circa 150. La conseguenza è stata grave: in una piccola isola, con flora e fauna protette, una riduzione cospicua del patrimonio boschivo, in particolare dei lecci, ma anche di giovani arbusti, che quindi non si potevano più riprodurre. La soluzione drastica è stata l’abbattimento di 35 capi, nonostante le proteste animaliste, e il trasferimento di 52 in altre zone.
In Sardegna la popolazione attuale è abbastanza numerosa, con oltre 2.000 esemplari, dovuta anche ad introduzioni, che però potrebbero creare una certa competitività con i camosci. Dante Iagrossi (foto da Pixabay).
Fonti: Wikipedia, Ente gestione Aree protette (Alpi marittime), Ambiente.regione.emilia-romagna.