 Sono passati quasi tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 10 del 14 gennaio 2013 relativa alle “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Una legge che detta anche regole per la tutela del patrimonio paesaggistico e degli alberi monumentali.
Sono passati quasi tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 10 del 14 gennaio 2013 relativa alle “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Una legge che detta anche regole per la tutela del patrimonio paesaggistico e degli alberi monumentali.
Le norme, recepite o ancora da recepire dalle varie Regioni, cercano di uniformare le diverse iniziative regionali in campo forestale definendo anche le caratteristiche che devono avere gli alberi affinché possano definirsi “monumentali”. Questi “patriarchi” vegetali, opportunamente censiti, sono sottoposti ad una serie di vincoli e protezioni, con sanzioni amministrative e/o penali per il loro eventuale abbattimento. Comunque ogni eventuale intervento sugli stessi è sottoposto ad un parere obbligatorio e vincolante del Corpo Forestale dello Stato.
 Proprio questo Corpo dello Stato (oggi in fase di radicale riordino o di assorbimento da parte di altre forze di polizia) oltre trent’anni fa, nel 1982, diede inizio al primo “Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse”, che è stato aggiornato dalle varie Regioni italiane ma senza criteri univoci.
Proprio questo Corpo dello Stato (oggi in fase di radicale riordino o di assorbimento da parte di altre forze di polizia) oltre trent’anni fa, nel 1982, diede inizio al primo “Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse”, che è stato aggiornato dalle varie Regioni italiane ma senza criteri univoci.
In questa pagina si può aprire un file excel relativo ai dati degli alberi monumentali censiti nelle Regioni italiane (schede in basso, sulla barra di stato), con l’indicazione della località, del comune e della provincia, del nome scientifico, di quello volgare e di quello inglese della specie, dell’altezza e della circonferenza. Sono anche segnalati quegli esemplari ritenuti di “eccezionale valore storico e monumentale”.
Alcuni esempi:
La roverella (Quercus pubescens Willd.) di Crognaleto (TE) in Abruzzo, alta 17 m e con una circonferenza di 7,8 m;
Il pioppo nero (Populus nigra L.) di Lauria Superiore (PZ) in Basilicata, alto 31 m e con una circonferenza di 6,1 m;
Il pino laricio (Pinus laricio Poiret) di Spezzano Sila (CS) in Calabria, alto 43 m e con una circonferenza di 5,8 m;
Il platano orientale (Platanus orientalis L.) di Avella (AV) in Campania alto 22 m e con una circonferenza di 12,1 m;
L’araucaria (Araucaria cookii R. Br.) della Reggia di Caserta, alta 30 m e con una circonferenza di 4 m;
Il castagno (Castanea sativa Miller) di Camugnano (BO), in Emilia Romagna, alto 10 m e con una circonferenza di 8,4 m;
La farnia (Quercus robur L.) di Bertiolo (UD) in Riuli Venezia Giulia, alta 21 m e con una circonferenza di 8 m;
Il bosso (Buxus sempervirens L.) di Vetralla (VT) nel Lazio, alto 8 m e con una circonferenza di 13,4 m;
Il faggio (Fagus sylvatica L.) di Mallare (SV) in Liguria, alto 35 m e con una circonferenza di 7,7 m;
Il cedro del Libano (Cedrus libani A. Richard) di Villa Mirabello (VA) in Lombardia, alto 28 m e con una circonferenza di 11,3 m;
Il tasso (Taxus baccata L.) di Serra Sant’Abbondio (PS) nelle Marche, alto 15 m e con una circonferenza di 4,8 m;
L’acero montano (Acer psudoplatanus L.) di Pizzone (IS) in Molise, alto 18 m e con una circonferenza di 6,6 m;
La sequoia gigante (Sequoiadendron giganteum, Lindl. Bucholtz) di Roccavione (CN) in Piemonte, alta 42 m e con una circonferenza di 9,9 m;
Il leccio (Quercus ilex L.) di Vico del Gargano (FG) in Puglia, alto 17 m e con una circonferenza di 5,1 m;
La vallonea (Quercus aegilops L.) di Tricase (LE) in Puglia, alta 15 m e con una circonferenza di 4 m;
Il leccio (Quercus ilex L.) di Ogosolo (NU) in Sardegna, alto 28 m e con una circonferenza di 7,6 m;
L’olivastro (Olea europaea L., var, Sylvestris Brot.) di Luras (SS) in Sardegna, alto 14 m e con una circonferenza di 11,8 m, considerato anche l’albero più vecchio d’Italia, con i suoi duemila anni e oltre;
Il castagno (Castanea sativa Miller) di Sant’Alfio (CT) o castagno dei cento cavalli, in Sicilia, alto 22 m e con una circonferenza di 22 m;
La sughera (Quercus suber L.) di Niscemi (CL) in Sicilia, alta 17 m e con una circonferenza di 5,7 m;
Il cipresso (Cupressus sempervirens L.) di Vicchio Mugello (FI) in Toscana, alto 15 m e con una circonferenza di 5,7 m;
Il larice (Larix decidua Miller) di Ultimo (BZ) in Trentino Alto Adige, alto 28 m e con una circonferenza di 8,2 m;
L’olivo (Olea europaea L.) di Trevi (PG) in Umbria, alto 6 m e con una circonferenza di 9,1 m;
Il tiglio selvatico (Tilia cordata Miller) di Todi (PG) in Umbria, alto 16 m e con una circonferenza di 5,7 m;
L’ippocastano (Aesculus hippocastanum L.) di Donnas (AO) in Val D’Aosta, alto 25 m e con una circonferenza di 5,6 m;
Il platano (Platanus orientalis L.) di Caprino Veronese (VR) in Veneto, alto 16 m, con una circonferenza di oltre 10 m.
Ciascuno può aprire la scheda della Regione che gli interessa, considerando che il censimento è soggetto ad aggioramenti e modifiche.
Quali sono le caratteristiche che definiscono un albero “monumentale”?
“ a) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita’ e longevita’, per eta’ o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita’ botanica e peculiarita’ della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.”
Nelle immagini (cliccarci su per ingrandirle un po’): il tronco dell’olivastro millenario di Luras; la chioma del castagno dei “cento cavalli” di Sant’Alfio (www.comunesantalfio.gov.it/).

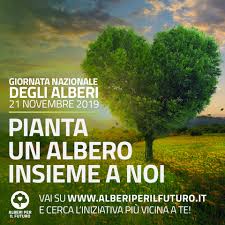




 Le piante sono organismi vegetali autotofri che hanno una propria struttura e una propria organizzazione. Quelle erbacee, arbustive e arboree sono provviste di organi specializzati: radici, fusto e foglie. Gli alberi sono piante legnose i cui rami partono dal tronco solo ad iniziare da una certa distanza dal suolo; hanno dimensioni variabili da pochi metri a molte decine di metri.
Le piante sono organismi vegetali autotofri che hanno una propria struttura e una propria organizzazione. Quelle erbacee, arbustive e arboree sono provviste di organi specializzati: radici, fusto e foglie. Gli alberi sono piante legnose i cui rami partono dal tronco solo ad iniziare da una certa distanza dal suolo; hanno dimensioni variabili da pochi metri a molte decine di metri. Cosa dire di viali alberati, giardini e parchi? Oltre ad essere un luogo di svago e di pratica sportiva e svolgere le funzioni generali delle piante già descritte, svolgono alcune funzioni specifiche. Ad esempio, nelle città o lungo strade e autostrade attenuano il rumore del traffico (barriere antirumore), talvolta anche di molto a seconda delle specie utilizzate e delle caratteristiche delle vie di comunicazione. Filari di alberi ai lati delle strade extraurbane svolgono anche un’importante funzione frangivento rendendo meno pericolosa la circolazione,
Cosa dire di viali alberati, giardini e parchi? Oltre ad essere un luogo di svago e di pratica sportiva e svolgere le funzioni generali delle piante già descritte, svolgono alcune funzioni specifiche. Ad esempio, nelle città o lungo strade e autostrade attenuano il rumore del traffico (barriere antirumore), talvolta anche di molto a seconda delle specie utilizzate e delle caratteristiche delle vie di comunicazione. Filari di alberi ai lati delle strade extraurbane svolgono anche un’importante funzione frangivento rendendo meno pericolosa la circolazione,  Sono passati quasi tre anni dall’entrata in vigore della
Sono passati quasi tre anni dall’entrata in vigore della  Proprio questo Corpo dello Stato (oggi in fase di radicale riordino o di assorbimento da parte di altre forze di polizia) oltre trent’anni fa, nel 1982, diede inizio al primo “Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse”, che è stato aggiornato dalle varie Regioni italiane ma senza criteri univoci.
Proprio questo Corpo dello Stato (oggi in fase di radicale riordino o di assorbimento da parte di altre forze di polizia) oltre trent’anni fa, nel 1982, diede inizio al primo “Censimento nazionale degli alberi di notevole interesse”, che è stato aggiornato dalle varie Regioni italiane ma senza criteri univoci.