 I prodotti biologici si trovano negli ipermercati da qualche decennio ma, oggi, è possibile trovarli anche nei negozi più piccoli e nei mercati rionali, sulle bancarelle, dove è più difficile verificare la loro autenticità. Quindi il biologico non è più solo una moda ma un settore importante dell’agricoltura e del commercio. I prodotti “bio” occupano aree sempre più vaste nei supermercati fino a formare, talvolta, intere corsie. I costi invece si mantengono sempre più alti rispetti ai corrispondenti prodotti non biologici ma questo non spaventa chi è attento ad un’alimentazione di qualità e non deve combattere con difficoltà economiche quotidiane.
I prodotti biologici si trovano negli ipermercati da qualche decennio ma, oggi, è possibile trovarli anche nei negozi più piccoli e nei mercati rionali, sulle bancarelle, dove è più difficile verificare la loro autenticità. Quindi il biologico non è più solo una moda ma un settore importante dell’agricoltura e del commercio. I prodotti “bio” occupano aree sempre più vaste nei supermercati fino a formare, talvolta, intere corsie. I costi invece si mantengono sempre più alti rispetti ai corrispondenti prodotti non biologici ma questo non spaventa chi è attento ad un’alimentazione di qualità e non deve combattere con difficoltà economiche quotidiane.
In origine, precursori dell’agricoltura biologica sono stati i contadini diffidenti verso un uso sempre crescente di fitofarmaci e insetticidi. Anche quella fascia di popolazione sensibile alle tematiche ambientali e etichettata come “verdi” ha sempre sostenuto il ritorno ad un’agricoltura e ad un allevamento biologici. Sono stati proprio i verdi a portare avanti, dagli anni ’80 ad oggi, trent’anni di battaglie culturali, giuridiche e politiche. L’agricoltura biologica ammette solo prodotti naturali per le pratiche agricole e l’allevamento. Sono esclusi quindi i prodotti chimici industriali e i prodotti OGM. Naturalmente ci sono anche altre ragioni che spingono per una continua sostituzione dei vecchi metodi di lotta con insetticidi: il vasto impiego di questi prodotti è stato sempre accompagnato, nelle tipologie di insetti trattati, dallo sviluppo di una sorta di resistenza genetica e, perciò, da una progressiva riduzione dell’efficacia del trattamento.
Ma quando e come i prodotti agricoli possono essere dichiarati biologici? Innanzitutto devono essere coltivati in terreni dove è stato sospeso l’impiego di sostanze chimiche di sintesi da almeno due anni e devono essere nettamente separati da altri terreni e colture non biologiche. Sono fondamentali poi, per mantenere la fertilità del suolo, alcune buone e antiche pratiche: l’utilizzo di fertilizzanti naturali (compost e letame animale), il sovescio per interrare piante (generalmente leguminose) seminate appositamente per la fertilizzazione, la rotazione delle colture per sfruttare diversi tipi di minerali e per ridurre lo sviluppo dei parassiti. Per quest’ultimo scopo si interviene anche con le normali pratiche di aratura e zappatura e con sostanze a base vegetale (ad esempio piretro) e favorendo lo sviluppo e l’azione di organismi antagonisti di quelli dannosi.
Per quanto riguarda gli allevamenti, sono esclusi quelli in batteria ed è escluso l’uso di antibiotici che, per qualche decennio, sono stati utilizzati massicciamente a scopo preventivo insieme agli ormoni per accelerare la crescita, soprattutto di specie avicole e di bovini. Per la conservazione dei prodotti non sono ammessi coloranti e conservanti chimici. Purtroppo però anche questo settore non è immune dalle frodi, anche se le aziende che vogliono ottenere per i loro prodotti i marchi “bio” sono sottoposte a controlli da parte di una delle agenzie riconosciute per il rilascio a livello italiano o europeo. Si tratta perciò di un’agricoltura controllata in base a regolamenti nazionali ed europei. Questi controlli invece non esistono per l’agricoltura convenzionale e sono molto ridotti per l’agricoltura “integrata” che in parte prevede l’utilizzo anche delle sostanze chimiche di sintesi. In Italia, per i controlli sono riconosciute una decina di agenzie: AIAB, Bioagricoop, Bios, CCPB, Codex, Ecocert Italia, IMC, AC & I, Suolo e Salute, Amab, Demeter, Biozart, Imo. Questo ci aiuta a capire perché l’agricoltura biologica ha un costo maggiore. Non solo per la necessità di ottenere le certificazioni, che hanno un costo, e per i controlli che i tecnici effettuano sul campo e in azienda ma anche perché i fertilizzanti sono più cari, la resa per ettaro del prodotto è inferiore, la difesa biologica è più costosa e, spesso, meno efficace. Tutto questo in passato ha fatto salire i prezzi fino al 100% in più rispetto a quelli non biologici ma, negli ultimi, anni questa differenza è meno marcata.
Non bisogna trascurare un aspetto sociale e sanitario: una percentuale significativa di malattie tumorali ha origine alimentare, dovuta proprio ai residui di pesticidi che si trovano negli alimenti vegetali (frutta, verdura, ortaggi) e agli antibiotici contenuti nelle carni. Un’alimentazione rivolta maggiormente ai prodotti biologici potrebbe ridurre malattie, morti e costi sociali. Ricordo un conoscente e amico che, proprietario di un frutteto trattato con fitofarmaci, mostrando una cassetta di mele molto grandi e belle diceva: “una di queste ti guarisce!”. Dopo pochi anni, non ancora sessantenne è deceduto per un tumore all’intestino. Purtroppo di casi simili, negli ultimi anni, ce ne sono stati tanti. Frutta e carni non vanno demonizzate ma bisogna fare attenzione alla loro origine e la prima va consumata sempre lavata e sbucciata, le carni vanno consumate con molta moderazione.
L’immagine è tratta da www.madeinitalyblognetwork.it/tag/biologico/





 La scorsa settimana, a Roma nella sede nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori, c’è stato un interessante convegno su come utilizzare lo sviluppo dell’agricoltura e del patrimonio boschivo, anche per ridurre gradualmente la concentrazione di biossido di carbonio dall’atmosfera. Nel Convegno sul clima di Parigi si è discusso di tante cose ma questa strada, che può offrire anch’essa un contributo al grave problema dell’aumento della temperatura globale che sta causando i cambiamenti climatici in atto, è stata decisamente trascurata. Invece sarebbe fondamentale per il clima, intervenire per mantenere un’elevata percentuale di suolo forestale in tutte le parti del pianeta dove è possibile. Allo stesso modo, il ritorno all’utilizzo dei suoli agricoli, dove sono stati abbandonati e la riduzione del consumo di suolo, soprattutto quando viene fatto a vantaggio di attività che determinano un aumento di CO
La scorsa settimana, a Roma nella sede nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori, c’è stato un interessante convegno su come utilizzare lo sviluppo dell’agricoltura e del patrimonio boschivo, anche per ridurre gradualmente la concentrazione di biossido di carbonio dall’atmosfera. Nel Convegno sul clima di Parigi si è discusso di tante cose ma questa strada, che può offrire anch’essa un contributo al grave problema dell’aumento della temperatura globale che sta causando i cambiamenti climatici in atto, è stata decisamente trascurata. Invece sarebbe fondamentale per il clima, intervenire per mantenere un’elevata percentuale di suolo forestale in tutte le parti del pianeta dove è possibile. Allo stesso modo, il ritorno all’utilizzo dei suoli agricoli, dove sono stati abbandonati e la riduzione del consumo di suolo, soprattutto quando viene fatto a vantaggio di attività che determinano un aumento di CO
 Il tema dell’EXPO Milano 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” vuole portare al centro dell’attenzione per tutti i Paesi, i problemi del cibo, della sostenibilità ambientale e del benessere umano.
Il tema dell’EXPO Milano 2015 “Nutrire il pianeta, Energia per la vita” vuole portare al centro dell’attenzione per tutti i Paesi, i problemi del cibo, della sostenibilità ambientale e del benessere umano.
 Si tratta di una delle manifestazioni di Slow Food legate al cibo, all’ambiente, all’agricoltura sostenibile, all’alimentazione e alla biodiversità. Una di quelle che hanno avuto maggior successo. Tra le tante interessanti iniziative, nell’ambito del Salone iniziato l’altro ieri e che si concluderà il 27 ottobre, ricordo: “10.000 orti per l’Africa”, “L’Arca del gusto”, “Percorso di biodiversità”, “Agricoltura familiare”, “Pane libero”, “Storie e culture dei migranti”, “Solidale italiano”.
Si tratta di una delle manifestazioni di Slow Food legate al cibo, all’ambiente, all’agricoltura sostenibile, all’alimentazione e alla biodiversità. Una di quelle che hanno avuto maggior successo. Tra le tante interessanti iniziative, nell’ambito del Salone iniziato l’altro ieri e che si concluderà il 27 ottobre, ricordo: “10.000 orti per l’Africa”, “L’Arca del gusto”, “Percorso di biodiversità”, “Agricoltura familiare”, “Pane libero”, “Storie e culture dei migranti”, “Solidale italiano”. Il costo non proprio “economico” del biglietto d’ingresso (20 euro) tiene lontano molte persone interessate, soprattutto giovani, e contrasta con i principi di “sostenibilità” e “solidarietà” portati avanti dalla fondazione slow food. Ma forse si rivolge solo a una determinata fascia di cittadini ed è un evento prevalentemente (se non esclusivamente) commerciale.
Il costo non proprio “economico” del biglietto d’ingresso (20 euro) tiene lontano molte persone interessate, soprattutto giovani, e contrasta con i principi di “sostenibilità” e “solidarietà” portati avanti dalla fondazione slow food. Ma forse si rivolge solo a una determinata fascia di cittadini ed è un evento prevalentemente (se non esclusivamente) commerciale. Qual è lo scopo fondamentale dell’Arca? Arrestare o ridurre il progressivo impoverimento della biodiversità nel settore alimentare e in quello agricolo. Per ogni prodotto segnalato, una minima parte rispetto alla grande quantità di materiali e sapori che si stanno perdendo nelle varie aree del pianeta, viene indicata la provenienza, l’anno di inserimento, i cenni storici, le immagini e talvolta un video descrittivo.
Qual è lo scopo fondamentale dell’Arca? Arrestare o ridurre il progressivo impoverimento della biodiversità nel settore alimentare e in quello agricolo. Per ogni prodotto segnalato, una minima parte rispetto alla grande quantità di materiali e sapori che si stanno perdendo nelle varie aree del pianeta, viene indicata la provenienza, l’anno di inserimento, i cenni storici, le immagini e talvolta un video descrittivo.
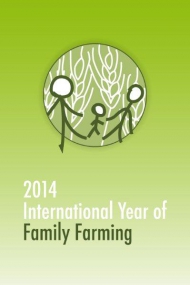

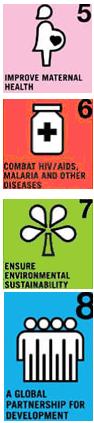
 Per molti l’agricoltura è qualcosa di sconosciuto. Per altri è solo un ricordo, di quand’erano bambini e nei campi lavoravano genitori e nonni. Eppure l’agricoltura, anche nelle grandi città, permette l’arrivo di cibo fresco: frutta e verdure soprattutto. Ma anche gli altri prodotti, più o meno lavorati, confezionati, provengono in ultima analisi dall’agricoltura e dagli allevamenti: pane, pasta, riso, vino, latte, formaggi, uova, salumi. In questi ultimi anni, all’inizio del XXI secolo, l’agricoltura sta attraversando la sua più grave crisi dal secondo dopoguerra. Si tratta di una crisi economica perché i prodotti agricoli all’origine hanno sempre meno valore, mentre quelli lavorati che ne derivano hanno costi sempre più alti per i consumatori finali. Associata a quella economica c’è quella delle persone: gli addetti al settore agricolo sono sempre meno e le campagne si svuotano. In alcuni casi questo vuoto viene occupato dall’agricoltura intensiva, più spesso invece, non solo nelle zone montane e collinari ma anche in pianura, rimangono vaste aree incolte. Che pena osservare campi incolti a soli 10 km da Torino! Secondo dati forniti da FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) le aziende agricole tra il 2000 e il 2010 si sono ridotte del 27% e quelle con allevamenti addirittura del 50%. Alcuni che avevano la possibilità di investire hanno trasformato l’azienda agricola in azienda agrituristica. Anche in questo caso però, senza agricoltura e allevamento, non avranno vita facile. Bisogna evitare di penalizzare le piccole aziende, com’è sempre successo, e non insistere nell’aiuto dei grandi gruppi formati dai soliti furbi. La faccenda delle “quote latte” che in alcune regioni si trascina da anni ne è un esempio.
Per molti l’agricoltura è qualcosa di sconosciuto. Per altri è solo un ricordo, di quand’erano bambini e nei campi lavoravano genitori e nonni. Eppure l’agricoltura, anche nelle grandi città, permette l’arrivo di cibo fresco: frutta e verdure soprattutto. Ma anche gli altri prodotti, più o meno lavorati, confezionati, provengono in ultima analisi dall’agricoltura e dagli allevamenti: pane, pasta, riso, vino, latte, formaggi, uova, salumi. In questi ultimi anni, all’inizio del XXI secolo, l’agricoltura sta attraversando la sua più grave crisi dal secondo dopoguerra. Si tratta di una crisi economica perché i prodotti agricoli all’origine hanno sempre meno valore, mentre quelli lavorati che ne derivano hanno costi sempre più alti per i consumatori finali. Associata a quella economica c’è quella delle persone: gli addetti al settore agricolo sono sempre meno e le campagne si svuotano. In alcuni casi questo vuoto viene occupato dall’agricoltura intensiva, più spesso invece, non solo nelle zone montane e collinari ma anche in pianura, rimangono vaste aree incolte. Che pena osservare campi incolti a soli 10 km da Torino! Secondo dati forniti da FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) le aziende agricole tra il 2000 e il 2010 si sono ridotte del 27% e quelle con allevamenti addirittura del 50%. Alcuni che avevano la possibilità di investire hanno trasformato l’azienda agricola in azienda agrituristica. Anche in questo caso però, senza agricoltura e allevamento, non avranno vita facile. Bisogna evitare di penalizzare le piccole aziende, com’è sempre successo, e non insistere nell’aiuto dei grandi gruppi formati dai soliti furbi. La faccenda delle “quote latte” che in alcune regioni si trascina da anni ne è un esempio. I prodotti biologici si trovano negli ipermercati da qualche decennio ma, oggi, è possibile trovarli anche nei negozi più piccoli e nei mercati rionali, sulle bancarelle, dove è più difficile verificare la loro autenticità. Quindi il biologico non è più solo una moda ma un settore importante dell’agricoltura e del commercio. I prodotti “bio” occupano aree sempre più vaste nei supermercati fino a formare, talvolta, intere corsie. I costi invece si mantengono sempre più alti rispetti ai corrispondenti prodotti non biologici ma questo non spaventa chi è attento ad un’alimentazione di qualità e non deve combattere con difficoltà economiche quotidiane.
I prodotti biologici si trovano negli ipermercati da qualche decennio ma, oggi, è possibile trovarli anche nei negozi più piccoli e nei mercati rionali, sulle bancarelle, dove è più difficile verificare la loro autenticità. Quindi il biologico non è più solo una moda ma un settore importante dell’agricoltura e del commercio. I prodotti “bio” occupano aree sempre più vaste nei supermercati fino a formare, talvolta, intere corsie. I costi invece si mantengono sempre più alti rispetti ai corrispondenti prodotti non biologici ma questo non spaventa chi è attento ad un’alimentazione di qualità e non deve combattere con difficoltà economiche quotidiane.