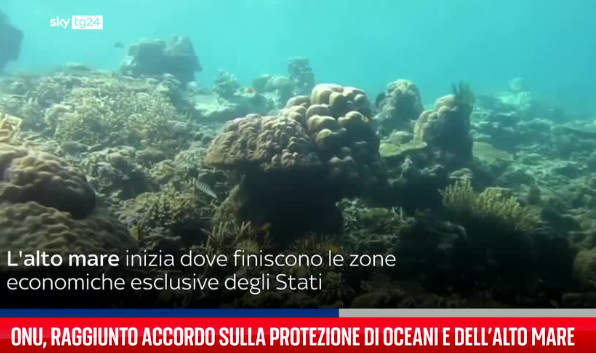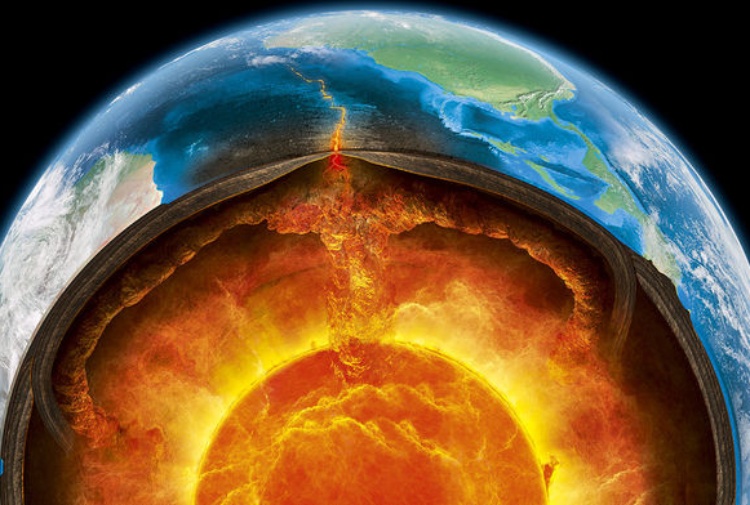Dante Iagrossi. Ormai è divenuto il principale nemico della salute dei nostri mari ed oceani, ma potrebbe compromettere seriamente anche la nostra. L’inquinamento da plastiche continua e sta assumendo forme colossali, difficilmente controllabili. Con conseguenze davvero gravi, di cui purtroppo non ci rendiamo conto abbastanza, ma da fronteggiare in modo repentino ed efficace.

Le plastiche ed i loro usi
Quasi tutti i materiali plastici si ottengono dal petrolio, rompendone le lunghe catene a base di carbonio in altre più piccole (monomeri), riagganciate poi in nuove catene, polimeri. Due le categorie principali:
- termoplastiche, ammorbidibili col riscaldamento e modellabili.
- termoindurenti, che non possono essere più modellate.
Le materie plastiche vengono poi trasformate in una serie di tantissimi manufatti: buste, piatti, bottiglie, contenitori vari, ecc.
Ci sono 7 fondamentali tipologie di plastica, tra cui:
PET (Polietilene Tereftalato), che costituisce il 96% di bottiglie e contenitori. Può essere facilmente riciclata per realizzare svariati oggetti.
HDPE (Polietilene ad alta densità), molto usata per contenitori di succhi, sacchetti per spesa, flaconi e giocattoli. La più riciclata, per la buona resistenza al caldo e al freddo.
PVC (Cloruro di polivinile), adoperata per piastrelle, scarpe, grondaie, infissi, con varie tossine. Difficile da riciclare.
LDPE (Polietilene a bassa densità), per pellicole per cibo, bottiglie, sacchetti per spesa e coperchi flessibili.
Dati allarmanti
Circa 8,8 milioni di tonnellate di plastica entrano in mari ed oceani, di cui l’80% deriva da fonti terrestri. Con questo ritmo, si prevede che forse entro il 2050 il peso della plastica supererà quello dei pesci! Inoltre, il 40% di tutta la plastica prodotta è adoperata una sola volta (monouso): ad es. le cannucce e i cottonfioc vengono subito buttati via. L’Italia risulta la prima nazione in Europa (e seconda nel mondo) per consumo di acqua minerale imbottigliata: più di 11 miliardi di bottiglie all’anno! Per smaltire un sacchetto di plastica tradizionale, occorrono dai 10 ai 30 anni circa, molto maggiori quella di oggetti di plastica dura.
Il destino della plastica (e conseguenze)
Mediamente nel mondo solo il 15% circa della plastica viene riciclata, la maggior parte o è rilasciata in ambiente, oppure raccolta in modo differenziato, per finire poi dentro discariche e termoconvettori.
La plastica in acqua, per l’azione del vento, di correnti marine e onde, ha già formato sei gigantesche isole, le “Plastic Soups”, di cui due nel Pacifico, due nell’Atlantico, una nell’Indiano ed una nel Mediterraneo, tra la Corsica e la Toscana. Inoltre, per l’azione continua delle onde e del sale, la plastica si frammenta in pezzetti di lunghezza inferiore ai 5 mm: le microplastiche. Queste tendono ad assorbire pesticidi, fertilizzanti, scarichi industriali vari, cosmetici e detersivi. Gli organismi marini o le scambiano per cibo o comunque le ingoiano casualmente, trasmettendole nelle catene alimentari. Si hanno perciò da un lato, gravi disturbi di malnutrizione ed occlusione di stomaco e vie respiratorie, dall’altro, l’assorbimento delle sostanze chimiche, che incidono sul sistema ormonale e nervoso. Ormai certi uccelli marini soffrono di “plasticosi”, con danni permanenti all’intestino. Sono stati trovati residui di microplastiche e sostanze chimiche non solo in animali, ma anche in persone, nel sale marino, nell’acqua minerale, persino nel miele, e nell’aria respirata.
Che fare?
Innanzitutto, modificando certe nostre abitudini quotidiane, conviene rifiutare il più possibile la plastica monouso, usare borse e contenitori riusabili, evitare le stoviglie e le cannucce di plastica. Per prevenire ulteriori aumenti in acqua di oggetti di plastica, si dovrebbero creare sistemi di blocco alle foci di fiumi, oltre a ripulire periodicamente coste e spiagge da rifiuti. Qualcuno ha creato appositi apparecchi per aspirare le plastiche almeno in superficie, che però hanno ancora un utilizzo assai limitato.
In alternativa alle plastiche più adoperate, sono state create tre tipi di bioplastiche a partire sostanze naturali, (come cellulosa, fecola di patate e barbabietole da zucchero), tra cui quella biodegradabile a contatto con l’aria e quella compostabile, per l’azione di enzimi, batteri e funghi. Purtroppo le bioplastiche, hanno alcuni inconvenienti: costi maggiori e sfruttamento di legname boschivo.
Sono tanti i volontari che si offrono in queste iniziative importanti per un futuro migliore, non solo per noi, ma per tutto il mondo vivente, come Plastic Free, Mare vivo, Mare Pulito e 4Ocean. Iagrossi Dante (foto da Pixabay).