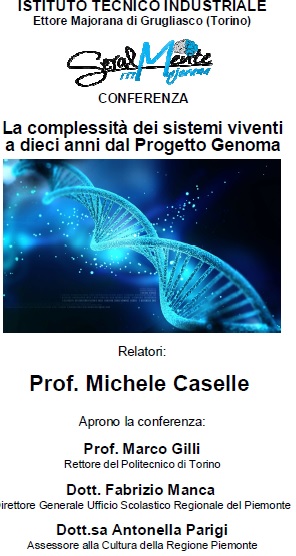Come capita spesso, piove sul bagnato. L’annata 2014 per l’olivicoltura è stata una delle peggiori degli ultimi decenni, con una netta diminuzione della produzione. Non bastava l’attacco di Xylella fastidiosa che sta falcidiando gli olivi del Salento, in Puglia; l’annata particolarmente piovosa ha facilitato la diffusione della mosca Bactrocera oleae. Questo parassita ha praticamente dimezzato la produzione di olive e olio nell’Italia centrale.
Come capita spesso, piove sul bagnato. L’annata 2014 per l’olivicoltura è stata una delle peggiori degli ultimi decenni, con una netta diminuzione della produzione. Non bastava l’attacco di Xylella fastidiosa che sta falcidiando gli olivi del Salento, in Puglia; l’annata particolarmente piovosa ha facilitato la diffusione della mosca Bactrocera oleae. Questo parassita ha praticamente dimezzato la produzione di olive e olio nell’Italia centrale.
In queste Regioni però il problema della mosca olearia è temporaneo, stagionale, ben diverso dalla gravità degli attacchi di Xylella che rischiano di distruggere o far abbattere gran parte degli ulivi anche secolari della Puglia. La Xylella fastidiosa è un batterio (in realtà sono diverse varietà di batteri) che attacca l’ulivo e le viti, in grado di spostarsi su altre specie di piante, veicolato da alcuni insetti, soprattutto Philaenus spumarius. Come agisce la Xylella? Prolifera e si diffonde nei vasi xilematici delle piante colpite e li ostruisce fino a provocare la morte dei rami ad essi collegati.
Il batterio è arrivato da pochi anni in Europa, si pensa nel 2008, determinando l’imbrunimento delle chiome e la conseguente morte delle piante colpite. Da una parte, il calo della produzione di olive ed olio ha determinato un aumento dei prezzi per i consumatori, dall’altra la rapida diffusione del batterio patogeno nel Salento sta cambiando il paesaggio delle zone colpite: decine di migliaia di ulivi morti, motoseghe che lavorano a pieno ritmo per l’abbattimento di quelli colpiti dall’epidemia.
Per arginare l’infezione o ridurne la velocità di diffusione e consentire la ricerca di efficaci metodi di prevenzione e cura (oggi non ne esiste alcuna) delle piante colpite, alcuni comuni hanno deciso di eliminare le piante infette o in fase di infezione, con specifiche ordinanze. Si tratta di un piano anti-epidemia predisposto dal commissario Giuseppe Silletti che ha ricevuto il benestare delle varie Istituzioni e un finanziamento di circa 13 milioni di euro, da attuare fino al prossimo otto agosto.
 La zona definita infetta, più una zona “cuscinetto”, corrisponde al territorio di tutta l’ex Provincia di Lecce. Sperando che gli abbattimenti da una parte e i trattamenti chimici contro gli insetti che lo trasmettono dall’altra, siano efficaci. Le conseguenze di queste decisioni sono drammatiche sulle popolazioni che vivono di olive, olio e turismo, sul bellissimo paesaggio del Salento, ma non intervenire farebbe estendere il dramma al resto della Puglia e progressivamente alle altre Regioni.
La zona definita infetta, più una zona “cuscinetto”, corrisponde al territorio di tutta l’ex Provincia di Lecce. Sperando che gli abbattimenti da una parte e i trattamenti chimici contro gli insetti che lo trasmettono dall’altra, siano efficaci. Le conseguenze di queste decisioni sono drammatiche sulle popolazioni che vivono di olive, olio e turismo, sul bellissimo paesaggio del Salento, ma non intervenire farebbe estendere il dramma al resto della Puglia e progressivamente alle altre Regioni.
Intanto i centri di ricerca fitosanitaria si stanno attivando per cercare possibili rimedi chimici e biologici, per sperimentare l’utilizzo di varietà di piante autoctone e verificare se sono resistenti al batterio parassita. La riduzione della biodiversità agricola degli ultimi decenni purtroppo facilita la diffusione di eventuali specie dannose. Tra le pratiche agricole utili a contrastare la diffusione dei vettori del batterio si suggerisce anche l’aratura dei campi delle zone infette, o sospettate di essere infette, in tempi brevi. Sono stati predisposti anche interventi a base di insetticidi entro il 30 maggio e entro il 30 luglio. Il contrasto dell’epidemia potrebbe richiedere anni, anche perché alcuni ritengono che sia meglio non fare nulla, aspettando che la natura stessa permetta di sviluppare una resistenza nelle piante colpite. Mi ritorna in mente la diffusione della “grafiosi dell’olmo” della seconda metà del secolo scorso, provocata dal fungo ascomicete Ophiostoma ulmi che ha portato alla morte in Italia del 100% degli esemplari adulti di olmo campestre (Ulmus campestris, U. minor). Sopravvivono le piccole piante, arbustive e alcune specie esotiche, tra cui l’olmo siberiano, Ulmus pumila,utilizzato nelle alberate urbane e nei parchi.
L’olmo però non ha la stessa importanza economica, paesaggistica, affettiva e agro-forestale dell’ulivo, perciò si spera che per difendere gli ulivi e le viti si attivi la ricerca di rimedi efficaci e che si pongano subito in atto idonee pratiche di prevenzione. Intanto la domenica delle palme, il prossimo 29 marzo, nel Salento sarà celebrata senza i tradizionali ramoscelli di ulivo, per non facilitare la diffusione del contagio.
Per approfondire: Opuscolo della Regione Lazio sulla Xylella fastidiosa .
Opuscolo della Regione Toscana .
Video:Zona di Parabita; video tutorial di Coldiretti Puglia;
In alto: foglie e rameti di ulivo sani; sotto: foglie, rametti e frutti secchi a causa della Xylella.




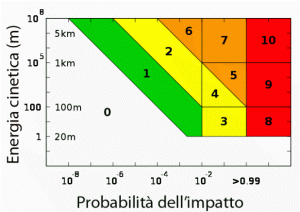 Il nome richiama la città sabauda ma si riferisce ad una scala internazionale che misura il pericolo di impatto di asteroidi e comete con la Terra. Il nome “scala Torino” gli venne attribuito nel 1999, durante un congresso internazionale sui corpi minori del Sistema Solare che potrebbero rappresentare un rischio per il nostro pianeta. Il nome “Torino” deriva dal fatto che quel congresso si tenne proprio nella città piemontese.
Il nome richiama la città sabauda ma si riferisce ad una scala internazionale che misura il pericolo di impatto di asteroidi e comete con la Terra. Il nome “scala Torino” gli venne attribuito nel 1999, durante un congresso internazionale sui corpi minori del Sistema Solare che potrebbero rappresentare un rischio per il nostro pianeta. Il nome “Torino” deriva dal fatto che quel congresso si tenne proprio nella città piemontese. Analogamente alla scala Richter per i terremoti, anche il rischio d’impatto dei NEO (
Analogamente alla scala Richter per i terremoti, anche il rischio d’impatto dei NEO ( La storia del nostro pianeta ci insegna che è solo questione di tempo: in quattro miliardi e mezzo di anni (età della Terra) ci sono stati centinaia di impatti catastrofici, perciò altri impatti si verificheranno certamente, in una scala temporale che non è quella della durata della vita umana, ma si parla di centinaia di migliaia di anni o milioni di anni.
La storia del nostro pianeta ci insegna che è solo questione di tempo: in quattro miliardi e mezzo di anni (età della Terra) ci sono stati centinaia di impatti catastrofici, perciò altri impatti si verificheranno certamente, in una scala temporale che non è quella della durata della vita umana, ma si parla di centinaia di migliaia di anni o milioni di anni.