 Se n’è andata ieri, all’età di 103 anni. Rita Levi Montalcini (Torino, 1909; Roma, 2012) era l’ultima di quel formidabile trio che negli anni ’30 del secolo scorso frequentò la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, denominata la “fabbrica dei Nobel”, dove dominava la personalità del professor Giuseppe Levi. Gli altri due sono stati: Salvador Edward Luria (Torino, 1912; Lexington, 1991), premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1969 per i suoi studi sul meccanismo di replicazione e sulla struttura genetica di batteri e virus; Renato Dulbecco (Catanzaro, 1914; La Jolla, 2012), premio Nobel per la Medicina e la fisiologia nel 1975 per le sue scoperte di forme virali cancerogene, è stato anche uno dei promotori del progetto di ricerca sul genoma umano.
Se n’è andata ieri, all’età di 103 anni. Rita Levi Montalcini (Torino, 1909; Roma, 2012) era l’ultima di quel formidabile trio che negli anni ’30 del secolo scorso frequentò la Facoltà di Medicina e Chirurgia di Torino, denominata la “fabbrica dei Nobel”, dove dominava la personalità del professor Giuseppe Levi. Gli altri due sono stati: Salvador Edward Luria (Torino, 1912; Lexington, 1991), premio Nobel per la medicina e la fisiologia nel 1969 per i suoi studi sul meccanismo di replicazione e sulla struttura genetica di batteri e virus; Renato Dulbecco (Catanzaro, 1914; La Jolla, 2012), premio Nobel per la Medicina e la fisiologia nel 1975 per le sue scoperte di forme virali cancerogene, è stato anche uno dei promotori del progetto di ricerca sul genoma umano.
Rita Levi Montalcini ottenne il suo premio Nobel per la Medicina e la fisiologia nel 1986, insieme a Stanley Cohen, per le ricerche sui meccanismi che regolano la crescita delle cellule, in particolare quelle nervose. Fondamentale fu la scoperta del “fattore NGF” o “fattore di accrescimento nervoso”, una sostanza proteica che stimola lo sviluppo delle cellule nervose indirizzandole verso le cellule bersaglio. Di Rita Levi ho già pubblicato un post con una sua lettera sul ruolo della scienza: “La Scienza non è un assoluto”, mentre di Renato Dulbecco ho trascritto un brano della sua autobiografia, di quando arriva a Torino per studiare e si presenta alle lezioni di Giuseppe Levi. Dalla stessa autobiografia, riporto un breve brano che descrive uno degli incontri con Rita Levi e il modo in cui entrambi si avvicinarono alla ricerca scientifica.
“Ogni anno Levi (Giuseppe) accettava alcuni studenti del secondo corso come interni nell’Istituto di Anatomia, dove facevano ricerca. Era il sancta sanctorum. La possibilità di diventare interno mi attrasse immediatamente, perché le ricerche non erano di anatomia, ma di biologia, e sentivo dire che Levi era ben conosciuto come biologo e citologo, più che come anatomista. Così mi presentai candidato. Venni accettato perché ero stato tra i migliori del primo anno. Come interno entravo in un mondo nuovo, dove lo spirito della ricerca dominava ogni altra considerazione, agendo da legame tra pochi individui che si staccavano dalla massa e formavano un collegio, nel senso antico della parola. … Tra gli interni c’era Rita Levi, che era del mio stesso anno. Eravamo stati immatricolati insieme, così la conoscevo già, e dopo la nostra ammissione all’internato diventammo buoni amici. …”
Nel 1992, Rita Levi-montalcini ha creato la “Fondazione Rita Levi-Montalcini Onlus” per favorire l’orientamento allo studio delle nuove generazioni.
Per saperne di più: http://it.wikipedia.org/wiki/Rita_Levi-Montalcini
http://www.ritalevimontalcini.org/
http://it.wikipedia.org/wiki/Renato_Dulbecco
http://it.wikipedia.org/wiki/Salvador_Luria

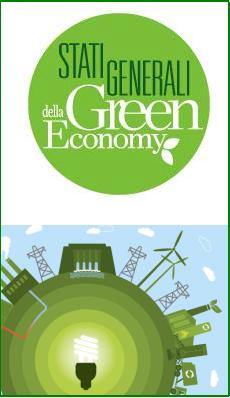
 Non si può negare che negli ultimi decenni nella sanità ci siano stati sprechi e abusi. Poiché la stragrande maggioranza del bilancio delle Regioni è incentrato sulla sanità, ci sono stati e ci sono anche corruzione e clientelismo. Servizi giornalistici ci hanno mostrato ospedali costruiti a metà e poi abbandonati, macchinari costati centinaia di migliaia di euro alla collettività e mai entrati in funzione (ma forse lo scopo era solo l’acquisto e non il loro uso). Dall’undicesimo (relativo al 2011) rapporto nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali in Italia, pubblicato qualche mese fa dall’Agenzia Italiana del Farmaco, si nota che la spesa farmaceutica italiana è in linea con quella degli altri principali Paesi europei. Anzi, la Francia, in rapporto al numero di abitanti, spende decisamente di più. Perciò bisogna combattere i “furbi”, i ladri e i corrotti e non prendersela indistintamente con tutti, con tagli “lineari”. Dai dati raccolti, per facilitare un confronto ho ricavato l’istogramma in basso.
Non si può negare che negli ultimi decenni nella sanità ci siano stati sprechi e abusi. Poiché la stragrande maggioranza del bilancio delle Regioni è incentrato sulla sanità, ci sono stati e ci sono anche corruzione e clientelismo. Servizi giornalistici ci hanno mostrato ospedali costruiti a metà e poi abbandonati, macchinari costati centinaia di migliaia di euro alla collettività e mai entrati in funzione (ma forse lo scopo era solo l’acquisto e non il loro uso). Dall’undicesimo (relativo al 2011) rapporto nazionale sulla sperimentazione clinica dei medicinali in Italia, pubblicato qualche mese fa dall’Agenzia Italiana del Farmaco, si nota che la spesa farmaceutica italiana è in linea con quella degli altri principali Paesi europei. Anzi, la Francia, in rapporto al numero di abitanti, spende decisamente di più. Perciò bisogna combattere i “furbi”, i ladri e i corrotti e non prendersela indistintamente con tutti, con tagli “lineari”. Dai dati raccolti, per facilitare un confronto ho ricavato l’istogramma in basso. Oggi i tagli che riguardano la sanità, anziché cercare gli sprechi e le inefficienze, colpiscono indiscriminatamente,
Oggi i tagli che riguardano la sanità, anziché cercare gli sprechi e le inefficienze, colpiscono indiscriminatamente, 
 Il termine “emisfero” in questo caso non è inteso come boreale o australe ma come superficie illuminata e superficie al buio. Abbiamo studiato i moti della Terra e le loro principali conseguenze, in particolare, il moto di rotazione intorno al proprio asse che si mantiene inclinato di 23°27’ rispetto alla verticale al piano dell’eclittica. Una delle principali conseguenze del moto di rotazione, che avviene da ovest verso est, è l’alternarsi del dì e della notte. Considerata la forma quasi “sferica” della Terra, il Sole in ogni istante ne illumina circa una metà, mentre la restante parte è al buio. La linea (immaginaria) in continuo movimento che sulla superficie terrestre separa il dì dalla notte, con un passaggio graduale caratterizato dai crepuscoli (dì-notte) e dall’alba (notte-dì), è detta circolo di illuminazione.
Il termine “emisfero” in questo caso non è inteso come boreale o australe ma come superficie illuminata e superficie al buio. Abbiamo studiato i moti della Terra e le loro principali conseguenze, in particolare, il moto di rotazione intorno al proprio asse che si mantiene inclinato di 23°27’ rispetto alla verticale al piano dell’eclittica. Una delle principali conseguenze del moto di rotazione, che avviene da ovest verso est, è l’alternarsi del dì e della notte. Considerata la forma quasi “sferica” della Terra, il Sole in ogni istante ne illumina circa una metà, mentre la restante parte è al buio. La linea (immaginaria) in continuo movimento che sulla superficie terrestre separa il dì dalla notte, con un passaggio graduale caratterizato dai crepuscoli (dì-notte) e dall’alba (notte-dì), è detta circolo di illuminazione. Colpisce la forte luminosità della Pianura padana e dell’area medio-orientale, dove non si bada al risparmio energetico né ci si pone il problema della riduzione dell’inquinamento luminoso. Alcune Regioni hanno cercato di ridurre questo fenomeno ma evidentemente con scarsi risultati. Negli ultimi anni, con la recessione in atto, sicuramente si riuscirà a fare di più.
Colpisce la forte luminosità della Pianura padana e dell’area medio-orientale, dove non si bada al risparmio energetico né ci si pone il problema della riduzione dell’inquinamento luminoso. Alcune Regioni hanno cercato di ridurre questo fenomeno ma evidentemente con scarsi risultati. Negli ultimi anni, con la recessione in atto, sicuramente si riuscirà a fare di più.


