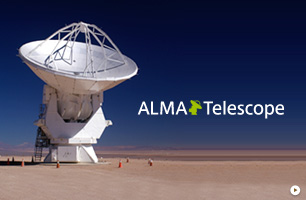Questo blog aderisce al manifesto in questione, che riporto integralmente. È stato presentato a Milano il 7 novembre 2011 e riportato su un’intera pagina a pagamento del Corriere della Sera, il 24 novembre 2011.
Questo blog aderisce al manifesto in questione, che riporto integralmente. È stato presentato a Milano il 7 novembre 2011 e riportato su un’intera pagina a pagamento del Corriere della Sera, il 24 novembre 2011.
Si tratta di un Manifesto, promosso da esponenti di organizzazioni di imprese e da imprenditori della green economy, che avanza una proposta, articolata in sette punti, per ”affrontare la crisi economica e sociale insieme a quella ecologica, riqualificando il nostro sviluppo nella direzione di una green economy”
I punti del manifesto sono i seguenti:
1. All’Italia serve una nuova strategia energetica basata su un incisivo programma di misure per l’efficienza e il risparmio di energia.
Questo programma deve fissare precisi obiettivi e promuovere azioni efficaci in diversi settori: dalla riqualificazione energetica degli edifici esistenti alla realizzazione di nuovi edifici a “consumi zero o quasi zero”; da una mobilità urbana più sostenibile a mezzi di trasporto a bassi consumi; dalla promozione della mobilità ciclopedonale allo spostamento di traffico su ferro, su mezzi collettivi e sul cabotaggio; dalla diffusione delle analisi energetiche dei processi produttivi e dei prodotti alla diffusione dei migliori standard, delle migliori pratiche e delle tecnologie ad alta efficienza energetica nell’industria e nei servizi. Investire risorse in una vera e propria rivoluzione del risparmio e dell’efficienza energetica è il modo migliore per ridurre la dipendenza e i costi delle importazioni, tagliare i costi delle bollette e le emissioni di gas serra, migliorare la competitività economica e creare migliaia di nuovi posti di lavoro. Le amministrazioni, a tutti i livelli, devono dare il buon esempio, con iniziative di risparmio energetico in tutte le strutture pubbliche. Le università e gli altri centri di ricerca vanno maggiormente coinvolti nello sviluppo e nella diffusione dell’innovazione per il risparmio e l’efficienza energetica, nella riqualificazione delle professionalità esistenti e nella formazione delle nuove figure professionali richieste.
2. L’Italia può ancora collocarsi fra i leader mondiali delle energie rinnovabili.
Occorre però muoversi in fretta, mantenendo adeguati ed economicamente sostenibili sistemi di incentivazione per il periodo ancora necessario e valorizzando il patrimonio di esperienza e capacità della nostra industria manifatturiera. Le fonti rinnovabili di energia avranno un ruolo crescente a livello internazionale. Per prevenire e mitigare la crisi climatica, la Conferenza internazionale di Cancun ha, infatti, raggiunto un accordo unanime sulla necessità di arrivare a tagli drastici delle emissioni di gas di serra. L’Italia, Paese povero di energia di origine fossile, ha un’occasione storica per sviluppare l’utilizzo delle sue diffuse fonti rinnovabili superando lo stesso obiettivo europeo del 2020 e, successivamente, potrebbe raggiungere target ancora più ambiziosi sia nel settore elettrico sia in quello termico, rafforzando le filiere produttive degli impianti, migliorando la rete e la capacità di accumulo e predisponendo quadri normativi e programmatici, nazionali e regionali, certi e adeguati
3. L’Italia deve diventare un campione mondiale dell’uso efficiente delle risorse e del riciclo.
In un Pianeta dotato di risorse limitate, in presenza di una domanda in forte e continua crescita, i costi e la disponibilità delle materie prime saranno elementi sempre più importanti per le possibilità di sviluppo. Le risorse naturali e ambientali vanno ormai considerate scarse e preziose. In Italia, Paese tradizionalmente povero di materie prime, non è più accettabile che la produzione di rifiuti cresca più del reddito e dei consumi. Sono necessarie concrete misure di prevenzione della produzione di rifiuti che coinvolgano i processi produttivi e la progettazione dei prodotti, la loro durata, il riuso e i modelli di consumo. Nonostante in diversi settori industriali, dalla siderurgia al tessile, dai mobili alla carta e al vetro, l’Italia sia storicamente un Paese impegnato nel riciclo, nonostante i passi avanti compiuti nei settori presidiati da forti sistemi di gestione, ancora quasi la metà dei rifiuti urbani – in alcune Regioni oltre l’80% – e la gran parte dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, finiscono in discarica. Per fare un salto in avanti nel riciclo dei rifiuti occorre diffondere sull’intero territorio nazionale le migliori pratiche di raccolta differenziata, estendendola anche alla frazione organica, occorre adeguare le dotazioni impiantistiche regionali, promuovere le migliori tecniche di riciclo e il mercato dei prodotti riciclati, anche per realizzare l’obiettivo europeo di avviare al riciclo almeno il 50% dei rifiuti urbani e il 70% dei rifiuti da costruzione e demolizione. Vanno sviluppati la ricerca, la produzione e l’uso efficiente non solo delle fonti energetiche, ma anche dei materiali rinnovabili che possono dare un importante contributo alla sostenibilità dello sviluppo futuro.
4. L’Italia deve meglio tutelare e meglio valorizzare il suo patrimonio culturale e naturale che è fra i più ricchi e importanti del mondo.
Il patrimonio culturale, storico e paesistico, è essenziale per la nostra stessa identità nazionale. Il patrimonio naturale, la disponibilità di acqua di buona qualità, di aria non inquinata, di un territorio vivibile, sono beni indispensabili per la qualità della nostra vita. Questi patrimoni hanno anche una grande importanza per molte attività economiche: dal turismo, col suo vasto indotto, alla filiera agroalimentare; dalle risorse idriche, dalla cui qualità e disponibilità dipendono diversi settori produttivi, alla promozione del made in Italy, associato ad un’idea di qualità e di bellezza del Paese. Non c’è futuro per l’Italia se non si conservano, con efficaci sistemi di tutela, e se non si valorizzano adeguatamente questi straordinari patrimoni. Va istituito un fondo per la tutela e la valorizzazione dei patrimoni culturali e naturali, alimentato con attività sostenibili, capaci di produrre ritorni economici, con particolare attenzione ad una migliore gestione e distribuzione dei flussi turistici. È tempo di definire le linee fondamentali per l’assetto del territorio italiano che dovrebbero costituire le basi per una riforma dell’urbanistica, tutelare le qualità ecologiche del nostro territorio e frenarne il consumo, stabilendo che non se ne impiega di nuovo se non si dimostra di non potere far fronte alle esigenze recuperando patrimonio esistente, accelerando le bonifiche e il riutilizzo dei siti contaminati e promuovendo la manutenzione e la prevenzione dei rischi di dissesto idrogeologico.
5. L’Italia deve puntare su un’elevata qualità ecologica e una nuova sobrietà.
Oltre a far bene all’ambiente, l’elevata qualità ecologica dei beni e dei servizi risponde alla domanda di un numero crescente di consumatori consapevoli e migliora la competitività sui mercati. Va assicurata una normativa ambientale di qualità europea, più semplice e stabile, con procedure di autorizzazione più veloci e con controlli efficaci. Va incoraggiata la tendenza in atto all’aumento del numero dei prodotti certificati con etichetta ecologica e delle imprese dotate di una certificazione ambientale. Un futuro sostenibile per l’Italia, Paese con un debito pubblico molto elevato e con un alto consumo di risorse naturali, richiede una nuova stagione di sobrietà e di riduzione degli sprechi sia finanziari, nelle spese come nei costi della politica e della pubblica amministrazione, sia di risorse naturali. È possibile avere nuovo sviluppo riducendo gli impatti ambientali, così come è possibile vivere meglio sprecando di meno. Un’economia sobria, fondata su un’elevata qualità ecologica, consentirebbe di assicurare maggiore coesione sociale e un benessere più equamente esteso in un Pianeta densamente popolato e dotato di risorse naturali limitate.
6. L’Italia deve rilanciare il protagonismo delle sue città, grandi e piccole.
Le comunità locali sono state i laboratori più capaci di comportamenti innovativi, basati sulla responsabilità, la creatività e lo spirito d’iniziativa. Sono riuscite spesso, anche in condizioni avverse, a produrre e mantenere qualità elevate, sia ambientali, sia economiche e sociali. Questa tendenza è confermata, per esempio, dai comuni Italiani che, nel numero più elevato d’Europa, hanno aderito al Patto europeo dei sindaci, adottando piani di politiche e misure impegnative per ridurre le emissioni di gas di serra. Occorre rilanciare lo sviluppo sostenibile locale valorizzando l’iniziativa delle città e dei territori, mobilitando saperi e competenze, coinvolgendo in modo attivo le imprese.
7. All’Italia serve maggiore consapevolezza e capacità di individuare un percorso di cambiamento e di sviluppo.
Stiamo vivendo un rischio concreto di declino non solo economico e ambientale, ma di fiducia nel futuro. Per la prima volta da decenni, le nuove generazioni nutrono fondati timori che il loro futuro possa essere peggiore di quello dei loro genitori. All’Italia serve un innovativo progetto di sviluppo, anche per il risanamento del suo ingente debito pubblico. Non vi può essere per l’Italia alcun vento a favore se il Paese non sa più dove andare, se per il suo futuro non dispone di un progetto condiviso di sviluppo. Non si risolvono i problemi mantenendo il modo di pensare che li ha prodotti. Per superare inerzie e carenze, ormai croniche, occorre una visione innovativa, capace di mobilitare le energie migliori del Paese, così come è avvenuto in passato, in momenti difficili. Le crisi non comportano solo difficoltà, ma anche opportunità di cambiamento. Siamo convinti che l’innovazione e la conversione ecologica possano dare un grande contributo ad un progetto condiviso di cambiamento perché, oggi più che mai, sono decisive non solo per tutelare l’ambiente, ma per produrre occupazione, rivitalizzare l’economia e creare opportunità di nuovo sviluppo.
Il sito del manifesto con il testo originale, il forum e per le eventuali adesioni:
http://www.manifestofuturosostenibile.it/
 In Sudafrica è in corso il summit del 2011 sui cambiamenti climatici (Cop 17). In tutto sono impegnate circa 15.000 persone dei vari Stati aderenti all’ONU. Discutono e cercano di concordare le misure più opportune e sostenibili da prendere per contrastare i cambiamenti climatici in atto che, tutto lascia prevedere, si aggraveranno.
In Sudafrica è in corso il summit del 2011 sui cambiamenti climatici (Cop 17). In tutto sono impegnate circa 15.000 persone dei vari Stati aderenti all’ONU. Discutono e cercano di concordare le misure più opportune e sostenibili da prendere per contrastare i cambiamenti climatici in atto che, tutto lascia prevedere, si aggraveranno.
 Si terrà tra qualche giorno a Milano il terzo Forum Internazionale sull’Alimentazione e la Nutrizione. Si tratta di un confronto tra esperti e studiosi sui problemi dell’alimentazione dell’umanità. Quali saranno i temi delle relazioni e dei dibattiti? Eccoli:
Si terrà tra qualche giorno a Milano il terzo Forum Internazionale sull’Alimentazione e la Nutrizione. Si tratta di un confronto tra esperti e studiosi sui problemi dell’alimentazione dell’umanità. Quali saranno i temi delle relazioni e dei dibattiti? Eccoli:

 Il disegno di legge sulle “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” è fermo, in attesa di essere esaminato, alla Camera dei Deputati. Tra le altre cose, prevede che il 21 novembre di ogni anno sia celebrata la giornata nazionale degli alberi. Se diventerà legge, l’iniziativa segue un’altra legge importante, anche da un punto di vista simbolico: la legge 113/1992, in base alla quale ogni Comune deve piantare un albero per ogni neonato che viene registrato all’ufficio anagrafe. Intanto tra qualche giorno, il 21 novembre 2011 verrà celebrata la seconda edizione della giornata nazionale dell’albero, su iniziativa del Ministero dell’Ambiente. La celebrazione in Italia si aggiunge all’anno internazionale delle foreste e alle celebrazioni del 150° dell’unità d’Italia e vede la partecipazione dell’
Il disegno di legge sulle “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” è fermo, in attesa di essere esaminato, alla Camera dei Deputati. Tra le altre cose, prevede che il 21 novembre di ogni anno sia celebrata la giornata nazionale degli alberi. Se diventerà legge, l’iniziativa segue un’altra legge importante, anche da un punto di vista simbolico: la legge 113/1992, in base alla quale ogni Comune deve piantare un albero per ogni neonato che viene registrato all’ufficio anagrafe. Intanto tra qualche giorno, il 21 novembre 2011 verrà celebrata la seconda edizione della giornata nazionale dell’albero, su iniziativa del Ministero dell’Ambiente. La celebrazione in Italia si aggiunge all’anno internazionale delle foreste e alle celebrazioni del 150° dell’unità d’Italia e vede la partecipazione dell’ Non potendo trattare in modo esaustivo, in poche righe, un’entità vivente complessa come l’albero, considererò soltanto una parte di questi laboratori della vita: l’apparato radicale. Si tratta della parte meno visibile e forse meno “nobile” dell’albero ma certo non la meno importante, ammesso che si possa fare una graduatoria sull’importanza delle varie strutture! Quest’apparato è costituito dalla radice primaria (nelle piante erbacee spesso non esiste una radice principale ma tante radici secondarie che, nel loro complesso determinano un apparato radicale fascicolato), dalle numerose radici secondarie e dai peli radicali. La parte terminale delle radici o zona apicale, è protetta da un rivestimento di cellule speciali: la cuffia, che periodicamente vede distrutta la parte esterna per l’attrito col terreno e continuamente viene rinnovata dalle cellule sottostanti. L’avanzamento dell’apice radicale, in profondità nel terreno, spesso è facilitato dall’azione chimica del biossido di carbonio prodotto dalla respirazione cellulare che, reagendo con l’acqua del suolo forma un acido debole, l’acido carbonico che favorisce la demolizione di certi minerali e il progressivo avanzamento della cuffia con la spinta delle cellule in accrescimento. Queste ultime appartengono alla zona meristematica, formata da cellule in continua divisione. Andando indietro, la capacità rigenerativa delle cellule decresce gradualmente e le cellule assumono una forma più allungata: siamo nella zona di allungamento in cui le cellule incominciano a differenziarsi nei due diversi tipi di tessuti vascolari: floema (preposto al trasporto verso il basso dei materiali organici elaborati dalle foglie) e xilema (adibito alla conduzione verso l’alto dei materiali assorbiti dalle radici). La zona successiva è quella pilifera in cui si completa la differenziazione delle cellule in tessuti e una parte del tessuto epidermico dà origine a numerosissime e speciali estroflessioni: i peli radicali. Sono strutture fondamentali, semplici o più spesso ramificate che aumentano enormemente la superficie di assorbimento. Per la funzione possiamo paragonarli ai nostri villi e microvilli intestinali. L’assorbimento dell’acqua dal terreno avviene soprattutto per osmosi (diffusione della stessa acqua, attraverso una membrana semipermeabile, come sono quelle cellulari, da una soluzione a minore concentrazione a una soluzione a concentrazione maggiore). Questo perché l’acqua del terreno contiene sali disciolti in concentrazione più bassa del citoplasma cellulare. Un’altra importante spinta all’assorbimento radicale è quella della traspirazione: di giorno gli stomi delle foglie sono aperti e una grande quantità d’acqua o vapore acqueo viene eliminata dalla pianta. Anche nelle radici la pressione dell’acqua si abbassa e questo favorisce un assorbimento passivo in cui le cellule radicali non svolgono alcun ruolo. Si tratta di un fenomeno fondamentale nelle piante terrestri. Nelle radici, per quanto riguarda l’accrescimento si individuano due tipi di tessuti: quelli primari responsabili dell’accrescimento in lunghezza e quelli secondari adibiti in prevalenza all’aumento del diametro radicale. L’accrescimento delle varie parti della pianta è regolato da diversi ormoni prodotti e diffusi nei liquidi in basse concentrazioni. I principali di questi ormoni sono l’auxina, le citochinine, le gibberelline e l’acido abscissico.
Non potendo trattare in modo esaustivo, in poche righe, un’entità vivente complessa come l’albero, considererò soltanto una parte di questi laboratori della vita: l’apparato radicale. Si tratta della parte meno visibile e forse meno “nobile” dell’albero ma certo non la meno importante, ammesso che si possa fare una graduatoria sull’importanza delle varie strutture! Quest’apparato è costituito dalla radice primaria (nelle piante erbacee spesso non esiste una radice principale ma tante radici secondarie che, nel loro complesso determinano un apparato radicale fascicolato), dalle numerose radici secondarie e dai peli radicali. La parte terminale delle radici o zona apicale, è protetta da un rivestimento di cellule speciali: la cuffia, che periodicamente vede distrutta la parte esterna per l’attrito col terreno e continuamente viene rinnovata dalle cellule sottostanti. L’avanzamento dell’apice radicale, in profondità nel terreno, spesso è facilitato dall’azione chimica del biossido di carbonio prodotto dalla respirazione cellulare che, reagendo con l’acqua del suolo forma un acido debole, l’acido carbonico che favorisce la demolizione di certi minerali e il progressivo avanzamento della cuffia con la spinta delle cellule in accrescimento. Queste ultime appartengono alla zona meristematica, formata da cellule in continua divisione. Andando indietro, la capacità rigenerativa delle cellule decresce gradualmente e le cellule assumono una forma più allungata: siamo nella zona di allungamento in cui le cellule incominciano a differenziarsi nei due diversi tipi di tessuti vascolari: floema (preposto al trasporto verso il basso dei materiali organici elaborati dalle foglie) e xilema (adibito alla conduzione verso l’alto dei materiali assorbiti dalle radici). La zona successiva è quella pilifera in cui si completa la differenziazione delle cellule in tessuti e una parte del tessuto epidermico dà origine a numerosissime e speciali estroflessioni: i peli radicali. Sono strutture fondamentali, semplici o più spesso ramificate che aumentano enormemente la superficie di assorbimento. Per la funzione possiamo paragonarli ai nostri villi e microvilli intestinali. L’assorbimento dell’acqua dal terreno avviene soprattutto per osmosi (diffusione della stessa acqua, attraverso una membrana semipermeabile, come sono quelle cellulari, da una soluzione a minore concentrazione a una soluzione a concentrazione maggiore). Questo perché l’acqua del terreno contiene sali disciolti in concentrazione più bassa del citoplasma cellulare. Un’altra importante spinta all’assorbimento radicale è quella della traspirazione: di giorno gli stomi delle foglie sono aperti e una grande quantità d’acqua o vapore acqueo viene eliminata dalla pianta. Anche nelle radici la pressione dell’acqua si abbassa e questo favorisce un assorbimento passivo in cui le cellule radicali non svolgono alcun ruolo. Si tratta di un fenomeno fondamentale nelle piante terrestri. Nelle radici, per quanto riguarda l’accrescimento si individuano due tipi di tessuti: quelli primari responsabili dell’accrescimento in lunghezza e quelli secondari adibiti in prevalenza all’aumento del diametro radicale. L’accrescimento delle varie parti della pianta è regolato da diversi ormoni prodotti e diffusi nei liquidi in basse concentrazioni. I principali di questi ormoni sono l’auxina, le citochinine, le gibberelline e l’acido abscissico. Le immagini del disastro causato dalla pioggia nelle Cinqueterre e in Lunigiana, seguite dalle alluvioni, dai poveri morti e dalle distruzioni di alcuni quartieri di Genova, sono ancora ben nitide nella nostra mente. Del resto, come è stato già scritto in passato (vedi
Le immagini del disastro causato dalla pioggia nelle Cinqueterre e in Lunigiana, seguite dalle alluvioni, dai poveri morti e dalle distruzioni di alcuni quartieri di Genova, sono ancora ben nitide nella nostra mente. Del resto, come è stato già scritto in passato (vedi  Sul versante della ricerca, un progetto europeo (METEOMET) volto a migliorare la misurazione dei cambiamenti climatici è stato vinto da un gruppo di ricercatori italiani dell’INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) che ha sede a Torino. L’INRIM è un ente pubblico di ricerca, che fa parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si occupa di scienza delle misure e dei materiali, sviluppa tecnologie e dispositivi innovativi. Per quanto riguarda la metrologia, ricordo anche che, tutti gli anni il 20 maggio, su iniziativa del Bureau International des Poids et Mesures di Sevres (Paris) si celebra la Giornata Mondiale della Metrologia per ricordare la Convenzione del metro del 20 maggio 1875. La fase attuativa del progetto meteomet invece è iniziata da circa un mese (1° ottobre 2011) sotto la guida del ricercatore Andrea Merlone che coordina un gruppo di altri giovani ricercatori. Il progetto è stato selezionato e finanziato con fondi europei e vede la partecipazione di una ventina di istituti di altrettante nazioni del continente. Di cosa si tratta? È un progetto triennale che si prefigge di migliorare le tecniche di misura dei parametri meteorologici: principalmente pressione, temperatura, umidità e velocità dell’aria nell’atmosfera. La finalità è quella di arrivare a strumenti di misurazione e dati più precisi e attendibili in modo da migliorare le previsioni meteorologiche e dare una migliore interpretazione ai dati meteorologici dei decenni e dei secoli scorsi. Il progetto prevede anche di favorire la creazione di un network di istituti meteorologici in grado di coordinare e collegare i vari istituti nazionali. Solo uno sforzo congiunto di vari Paesi potrà assicurare la partecipazione di ricercatori con competenze specifiche in vari ambiti scientifici e in metrologia. I nuovi strumenti e le nuove tecniche predisposte saranno sperimentate dai vari istituti meteorologici sparsi in tutta Europa. I risultati dovrebbero essere: dati più accurati e precisi, meglio interpretabili, che consentano migliori previsioni e valutazione dei rischi ed evitare o ridurre tragedie come quelle della Liguria e della Lunigiana, anche se il progetto nel suo complesso tende ad una maggiore comprensione dei cambiamenti climatici che si verificano su larga scala.
Sul versante della ricerca, un progetto europeo (METEOMET) volto a migliorare la misurazione dei cambiamenti climatici è stato vinto da un gruppo di ricercatori italiani dell’INRIM (Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica) che ha sede a Torino. L’INRIM è un ente pubblico di ricerca, che fa parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Si occupa di scienza delle misure e dei materiali, sviluppa tecnologie e dispositivi innovativi. Per quanto riguarda la metrologia, ricordo anche che, tutti gli anni il 20 maggio, su iniziativa del Bureau International des Poids et Mesures di Sevres (Paris) si celebra la Giornata Mondiale della Metrologia per ricordare la Convenzione del metro del 20 maggio 1875. La fase attuativa del progetto meteomet invece è iniziata da circa un mese (1° ottobre 2011) sotto la guida del ricercatore Andrea Merlone che coordina un gruppo di altri giovani ricercatori. Il progetto è stato selezionato e finanziato con fondi europei e vede la partecipazione di una ventina di istituti di altrettante nazioni del continente. Di cosa si tratta? È un progetto triennale che si prefigge di migliorare le tecniche di misura dei parametri meteorologici: principalmente pressione, temperatura, umidità e velocità dell’aria nell’atmosfera. La finalità è quella di arrivare a strumenti di misurazione e dati più precisi e attendibili in modo da migliorare le previsioni meteorologiche e dare una migliore interpretazione ai dati meteorologici dei decenni e dei secoli scorsi. Il progetto prevede anche di favorire la creazione di un network di istituti meteorologici in grado di coordinare e collegare i vari istituti nazionali. Solo uno sforzo congiunto di vari Paesi potrà assicurare la partecipazione di ricercatori con competenze specifiche in vari ambiti scientifici e in metrologia. I nuovi strumenti e le nuove tecniche predisposte saranno sperimentate dai vari istituti meteorologici sparsi in tutta Europa. I risultati dovrebbero essere: dati più accurati e precisi, meglio interpretabili, che consentano migliori previsioni e valutazione dei rischi ed evitare o ridurre tragedie come quelle della Liguria e della Lunigiana, anche se il progetto nel suo complesso tende ad una maggiore comprensione dei cambiamenti climatici che si verificano su larga scala. È iniziato novembre, il mese delle leonidi, meteore che, quando arrivano nella nostra atmosfera, lasciano una scia luminosa a causa dell’attrito e sembrano provenire tutte da una zona della volta celeste in cui si trova la costellazione del Leone.
È iniziato novembre, il mese delle leonidi, meteore che, quando arrivano nella nostra atmosfera, lasciano una scia luminosa a causa dell’attrito e sembrano provenire tutte da una zona della volta celeste in cui si trova la costellazione del Leone.